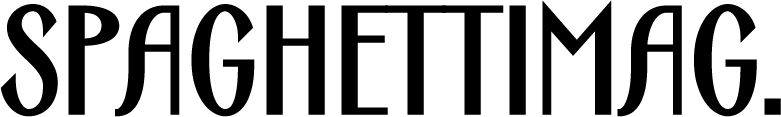Dalla piccola isola di Murano alla conquista del mondo
Luca Nichetto nasce come designer, senza sapere di esserlo. Dalle origini, nella sua Murano, alle ultime collaborazioni che lo vedono a fianco di nomi come Steinway & Sons e Angela Roi. La sua voglia di mettersi sempre in gioco, senza rifugiarsi nella comfort zone, fa di lui un designer multidisciplinare. Con molta umiltà, Luca, ci ha raccontato la sua passione e i suoi progetti.
La sua città di origine, Venezia, ha segnato in modo particolare il suo percorso. La sua ispirazione nasce infatti dalla famosa industria vetraria di Murano. Cosa ricorda di quei momenti in cui iniziava a capire che il design potesse essere la sua passione?
Inizialmente per me era del tutto normale ciò che facevo, mi piaceva disegnare e andare a studiare alla sezione vetro dell’Istituto d’Arte a Venezia era il passo più semplice. Ricordo che il fatto di essere di Murano, a maggior ragione essendo un’isola piccolissima, e di disegnare cose che potevano essere realizzate in vetro era per me un’occasione per guadagnarmi qualcosa. Una cosa molto divertente è che la spontaneità e il dialetto mi hanno sicuramente aiutato a entrare negli ambienti senza sentirmi fuori luogo, e anche sentire i gossip dei soffiatori di vetro su chi non era di Murano, mi faceva sentire uno di loro. Lo vedo ancora oggi, quando torno a Murano e giro per l’isola, che c’è un senso di orgoglio da parte delle persone che mi conoscono. Ho fatto tanti lavoretti e c’è stato un momento in cui, da studente di Industrial Design all’università, sono entrato in contatto con Salviati e in quel momento c’era il designer inglese Simon Moore a fare da art director per l’azienda, che all’epoca collaborava con mostri sacri. Nonostante ciò, Simon mi accolse senza giudicare se fossi conosciuto o meno, dandomi una grande chance. Ricordo che comprò tutti i miei disegni dicendomi che non li avrebbe mai realizzati e ciò mi spinse ad essere ancora più curioso di questo artista, che mi propose di frequentare quell’ambiente per spiegarmi di cosa ha bisogno un’azienda, insegnandomi anche tutto l’aspetto professionale, oltre la parte creativa.
Lo scorso 1° giugno, in occasione del Fuori Salone a Milano, ha presentato Projects, collaborations and conversations in design, un libro per celebrare i suoi 20 anni di carriera. Un volume che racchiude interviste, fotografie, bozzetti, aneddoti e tanto altro. Com’è arrivata l’ispirazione per questo progetto?
Probabilmente è stata una reazione all’autocelebrazione che spopola in diversi ambiti. Sicuramente c’è un momento in cui, arrivati alla consapevolezza di un percorso fatto, si vuole mettere un timbro. In questi vent’anni, oltre ai prodotti, ci sono tutte le storie che questi portano con sé. C’è tutto un mondo che spesso non viene messo in luce, proprio perché c’è questa sorta di autocelebrazione in cui al centro c’è solo l’autore, ma l’autore nel lavoro che facciamo non è nulla se non c’è qualcuno che realizza e aiuta a far diventare reale una visione. Per me è stato anche un modo per ringraziare e far capire che un libro di design, su uno studio di design, non è solo un catalogo dei progetti, ma c’è molto di più dietro. Avendo un approccio al lavoro molto trasversale e molto legato alla tradizione italiana di mettersi al servizio dell’azienda e non di essere solo l’autore per cui tutto deve essere al servizio del mio stile, ho voluto far capire che anche se l’output può essere diverso, c’è sempre un filo conduttore.
“Amiamo le persone e costruiamo comunità. Condividiamo la nostra passione per il design – con il nostro team, collaboratori, clienti; ogni incontro porta idee e prospettive significative”. Questo è uno dei punti cardine del manifesto su cui si basa il tuo studio, ci può parlare di com’è nato e dell’importanza del lavoro di squadra, nel suo caso?
Il primo studio è nato nel 2006 dalla necessità di pagare le tasse. Ho iniziato come freelance e all’epoca non esistevano studi di settore o la partita IVA a regime agevolato come al giorno d’oggi. Fortunatamente ho disegnato il primo progetto per Salviati che è diventato subito un best seller dell’azienda, poi altri oggetti per Foscarini e in tre, quattro anni la mia vita è cambiata radicalmente. Non ho mai lavorato in studio da nessuno, quindi sono stato un autodidatta, il che mi ha lasciato molte bruciature e cicatrici, e ho imparato che quando sei un libero professionista con partita IVA, devi sempre pensare che una parte del guadagno serve a pagare le tasse. Il mio commercialista mi consigliò di investire in uno studio e quindi nell’ottica di comprare lo studio mi consigliarono anche di aprire un’azienda. Questo è stato il primo passo non pianificato, poi nel 2011, alla mia compagna è stato offerto un lavoro importante a Stoccolma. Per un po’ ho fatto avanti e indietro, ma poi mi sono reso conto che lì non avevo nulla. Così ho deciso di aprire uno studio anche in Svezia, nell’ottica di mettere su famiglia e stabilirmi in pianta stabile. In tutto ciò ho capito che non era possibile giocare da solo, avevo bisogno di aiuto e così ho iniziato a creare una squadra capace di soddisfare le richieste che arrivavano all’azienda. Lo stesso concetto vale anche per le collaborazioni, perché quando realizziamo un progetto di qualsiasi tipo coinvolgiamo anche l’azienda committente e si crea un team allargato, in cui se si riesce ad avere un goal comune e ad aiutarsi a vicenda, sicuramente si raggiunge l’obiettivo e lo si fa in modo molto costruttivo e positivo. Se invece la si vive come una competizione, non si vede l’ora di finire quel progetto per iniziarne subito un altro.

Il 9 novembre scorso ha annunciato il lancio di Gran Nichetto limited edition per Steinway & Sons, un pianoforte dal design elegante e sofisticato, che unisce artigianalità, tecnologia e heritage. Cosa ha apprezzato maggiormente di questa collaborazione?
Il giorno dell’evento a New York, a un certo punto, Rufus Wainwright si è esibito cantando e suonando al pianoforte creato da noi. In quel momento ho provato una sensazione che non provavo da almeno vent’anni. Da una parte la felicità di vedere il risultato e gli apprezzamenti della gente, la fierezza di esserci riuscito, dall’altra un velo di tristezza per qualcosa che è finito e per un cerchio che si chiude. Avevo provato questa stessa sensazione solo alla fine del percorso universitario, con la laurea. Questo vuol dire che il progetto mi ha dato tantissimo dal punto di vista emotivo, perché non capita tutti i giorni di disegnare un pianoforte e soprattutto non capita tutti i giorni di disegnarlo per Steinway & Sons e di metterci il proprio nome. Inoltre, ero il primo italiano a lavorare con loro, quindi una serie di cose piuttosto importanti. È stato un progetto che ha rischiato di fermarsi sei, sette volte e ci sono stati progetti di strategia per far sì che si arrivasse a un dunque. È stato molto difficile e impegnativo, ma non credo che sarà qualcosa di passeggero, anzi penso sia abbastanza un timbro in un certo tipo di legacy che uno va a costruire.
Ha fatto da poco il suo debutto nel mondo degli accessori moda con la Malala Tote Collection, una borsa in materiale vegano e cruelty free, in collaborazione con il brand newyorkese Angela Roi. Com’è nata la collaborazione e cosa l’ha spinta a fare il suo ingresso in questo mondo?
Malala è nata da un’e-mail che ho ricevuto da Angela Roi, in cui mi spiegavano che gli piaceva il mio lavoro e il fatto che fossi trasversale, e che volevano aprire la loro azienda a una collaborazione con un designer esterno per necessità e sperimentazione. Mi ha incuriosito molto il payoff con cui è nata l’azienda di “not sacrifice animal leather”, infatti avevano l’intera collezione in pelle vegana, con l’idea di un lusso accessibile per la donna di tutti i giorni. Mi è piaciuta molto la sfida, e mi è piaciuto anche il fatto che l’azienda fondata in America, da Angela e Roi, che sono di origine coreana, producesse le borse in Corea. Nell’ambito di questo progetto, Angela ha voluto iniziare a sperimentare con pelli naturali e inizialmente ci ha sottoposto una pelle di cactus, che abbiamo subito capito essere bella ma troppo fragile. Inoltre, ci siamo resi conto che gli artigiani sudcoreani, a cui si appoggiavano, non avevano capito il tipo di progetto che volevamo realizzare, perché lo interpretavano in base alle loro conoscenze. A un certo punto Angela ci ha contattato dicendo che non era soddisfatta del risultato e che probabilmente il progetto non era realizzabile. Questo ha acceso in me un senso di sfida con me stesso e così le ho proposto di farlo realizzare in Italia. Abbiamo trovato un fornitore e abbiamo iniziato a lavorare con la pelle di mela, vedendo il primo prototipo, che ha convinto tutti, dopo tre, quattro mesi. È stata un’esperienza bellissima, perché al di là dell’estetica del design, mi piaceva l’idea di partire dal fatto che quando si cerca qualcosa nella borsa non la si trova mai, così ho pensato di rispondere a questa esigenza realizzando molte tasche.