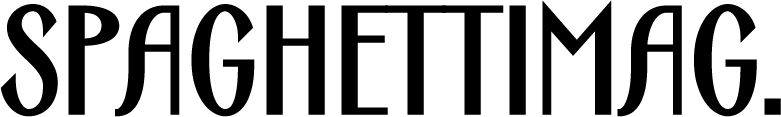La Sicilia, l’attaccamento alle radici e alle tradizioni della terra d’origine che non ha dimenticato per rincorrere quel sogno che è il mestiere dell’attore. La nostalgia e il ritorno, lo studio al Teatro Stabile di Genova e l’incontenibile passione per la recitazione che si è trasformata nel motore della sua vita. Insieme al talento che dimostra interpretando ruoli e personaggi diversi, spesso agli antipodi. Giuseppe De Domenico ha le idee chiare sul proprio futuro e la carriera attoriale che, lontana dalla logica del compiacimento, in altri termini chiamata popolarità, non deve perdere di vista l’essenza più profonda di sé e la coerenza. Così come quella personalità riconoscibile e decisa, che dimostra di avere raccontandosi senza paura.
Di origini siciliane, hai studiato, fino al diploma nel 2016, alla Scuola del Teatro Stabile di Genova. Il distacco dalla Sicilia è stato difficile? Cosa porti con te della tua terra?
«Quello che porto con me sono l’educazione, l’attaccamento alle radici e alle tradizioni. Torno sempre almeno tre volte all’anno. È stato più o meno traumatico perché faccio parte di quella generazione che, in massa, è stata costretta a muoversi verso il continente per andare a inseguire i propri sogni professionali e la carriera. Avendo deciso di fare l’attore, a maggior ragione dovevo necessariamente trasferirmi. Ci sono quei momenti in cui, a bordo della nave Caronte per attraversare lo stretto sul treno, avvicinarsi alla costa è sempre qualcosa di sentimentale e drammatico».
Quanto ha contato per te l’esperienza teatrale nella formazione attoriale? C’è chi preferisce esclusivamente il cinema al teatro: una questione di timidezza nell’affrontare il pubblico dal vivo o solo scarsa preparazione?
«Porto tutto con me, sono due lavori che per alcuni aspetti trovo profondamente diversi. A teatro siamo abituati a provare per tanti giorni fino alla rappresentazione davanti agli spettatori. Nelle varie repliche viene richiesto di fare la stessa cosa. Al cinema, invece, si è già proiettati in un mondo completamente differente: sono uno di quelli che all’inizio preferiva soltanto il teatro, poi grazie alla mia maestra, Anna Laura Messeri, la direttrice di Genova, ho ampliato le mie possibilità facendo richiesta in agenzia con i primi provini a cui hanno fatto seguito i primi progetti. Però la forma mentis e l’approccio vengono da un metodo che ho appreso durante gli anni della formazione teatrale».
Hai esordito sul grande schermo nel 2017 con “Euforia”, diretto da Valeria Golino. Che ricordo hai della prima volta in cui hai calcato un set cinematografico?
«È stato entusiasmante perché avevo lavorato nei sei mesi precedenti facendo come spalla: Francesco Vedovati al casting, Valeria alla regia e tutti i primi attori, come Paolo Pierobon e Pierfrancesco Favino, ai quali ho dato le battute nella fase iniziale dei provini. Mi sentivo protetto dalla figura della regista che mi prese sotto la sua ala. Una bella sensazione, non ho un aneddoto specifico, mi sono sentito abbastanza a casa».
In tv hai recitato, per la regia di Francesco Miccichè, nel docu-film Rai “Adesso tocca a me- Paolo Borsellino”. A trent’anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, pensi che l’Italia abbia finalmente imparato cosa vuol dire legalità?
«No, temo che viviamo tuttora in un’epoca che è soprattutto di facciata. A parole, esponenti politici e personalità influenti, che hanno il potere di mettere a tacere quel tipo di dinamiche, nolenti o volenti devono confrontarsi con quello che succede sottobanco. Sappiamo bene, senza citare le statistiche, quanto il nostro Paese sia in cima alle liste di corruzione. Le cose sono legate, c’è tantissima strada da fare sull’argomento».
Si celebrano gli eroi quando non ci sono più, mentre da vivi, spesso, si è molto bravi a osteggiarli. Cosa significa per te lotta alle mafie?
«La prima risposta che mi viene in mente è legata ad un concetto di trasparenza. Le mafie si costruiscono intorno all’idea di alcuni di creare uno stato alternativo a quello ufficiale. Molte persone trovavano in quel tipo di dinamiche e protezioni punti di riferimento in mancanza di un apparato statale reale che, se iniziasse a occuparsi dal basso di tutti cittadini, senza architettare giochi di potere per pochi, raggiungerebbe lo scopo di lottare concretamente contro la criminalità organizzata».
La serie televisiva internazionale “Zero Zero Zero” di cui hai fatto parte, e trasmessa in 103 Paesi nel mondo, è tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano. Lui non ha avuto paura di esporsi. C’è qualcosa che, invece, ti spaventa?
«Mi spaventa perdere la mia coerenza. Essendo il mio un mestiere nel quale si ha a che fare con l’esposizione pubblica, questa implica un concetto di compiacimento che, a sua volta, significa fare ciò che gli altri si aspettano non dando la priorità alle proprie esigenze personali. Ho paura di non avere più un contatto con me stesso per delle mere logiche di mercato, rimanendo con un titolo o un premio tra le mani solo per popolarità. E guardarsi allo specchio per chiedersi: chi sono realmente?».
Chi è il tuo personaggio in “Bang Bang Baby”, la prima serie Amazon Italia?
«Si chiama Rocco Cosentino, è un ragazzo molto giovane che non ha nessun rapporto con la famiglia mafiosa, fra intrecci e responsabilità di tipo criminale. Vive tutto con leggerezza, ed è stato uno degli elementi chiave in base al quale ho deciso di accettare il ruolo per raccontare una storia, interpretando un personaggio che fosse agli opposti rispetto a quello che avevo vestito in “Zero Zero Zero”, doppiogiochista e padrone delle situazioni. Ma non vorrei spoilerare troppo!».
Hai co-fondato “Laboratorium 57”, di cosa si tratta?
«Un progetto nato a ridosso dello scoppio della pandemia, nel 2020, insieme a Matteo Franco che è un attore e performer italiano di stanza in Olanda. Siamo stati un po’ frenati dal Covid, però l’obiettivo è dare vita ad un luogo di sperimentazione e ricerca per figure attoriali ed interpreti europei in un percorso che coinvolge anche docenti internazionali. Nell’ordine di idee in cui un workshop di recitazione insegna ad avere degli strumenti pratici su come affrontare un provino, una scena o un ruolo, dove di solito c’è chi suggerisce cosa funziona o meno, abbiamo assemblato un team nostro, e che la pensa come noi, in maniera tale che l’artista possa avere l’opportunità di capire ciò che va bene per sé stesso e al di là del vortice del compiacimento di cui parlavo. Si esprime attraverso la logica dell’accettazione dell’errore, secondo cui non possiamo essere perfetti. Nella recitazione cinematografica è la camera che fa il lavoro per te e non sei tu che devi raccontare uno stato psicoemotivo specifico».