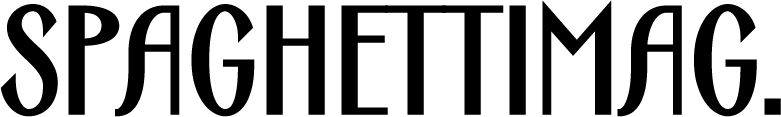Chiusura delle frontiere a parte, a Tokyo inizia il Grand Tour del XXI secolo.
È un viaggio estetico, perché nasce, letteralmente, in ragione della luce.
Nell’Europa di Goethe, si trattava di attraversare le Alpi verso il sole del Mediterraneo. Per le frotte di scrittori, artisti e gentiluomini che sciamano da Inghilterra, Francia e Germania alla volta di Venezia, Firenze, Roma e poi Napoli, l’Italia è lo scrigno della classicità. La sua bellezza arriva dal passato. Ecco in Giappone vale il contrario. Nell’isola di Honshu ci aspetta prevalentemente il futuro. Da quelle parti è una circostanza accaduta parecchi anni fa. Lo spirito della tradizione, pur essendo fortissimo, resta uno spirito, dunque una presenza immateriale, il che, forse, costituisce l’essenza della sua ipermodernità.
La luce giapponese è naturalmente una luce elettrica. Erano neon, adesso sono led. Il risultato non cambia. Anche il giorno sembra illuminato da una lampadina. Assomiglia a una gigantesca scenografia teatrale. Attraversarla è come avere la sensazione che, da un momento all’altro, arrivi un attrezzista a smontare tutto, con il caschetto, i guanti, e il gilet catarifragente. Perché in Giappone, ad ogni angolo c’è qualcuno con il caschetto, i guanti e un qualche complicato attrezzo di segnalazione luminosa, che assomiglia a una spada laser di Guerre Stellari.
Verrebbe da chiamarlo omino, ma sarebbe irrispettoso. Non c’è eleganza senza rispetto, perché l’eleganza e il rispetto qui sembrano occupare la maggior parte della giornata delle persone. Può essere utile considerare solo le apparenze. Nulla è certo, salvo l’orario dei treni.
Sulla moquette ovattata dell’aeroporto, non si sente il rumore dei passi. È un effetto mondo fluttuante da stampa Ukiyo-e: una certa atmosfera di sospensione della gravità. Non è la Luna, ma sicuramente un altro pianeta.
Difficile rispondere alla domanda che cos’è Tokyo. Un tentativo si fa verso l’idea di definire “che aspetto ha Tokyo”.
Quando si arriva in città con il monorail da Haneda, prevalgono grattacieli e riflessi di porpora sul mare, perché a Tokyo c’è anche il mare.
C’è tutto a Tokyo, ma non dappertutto, soltanto qua e là.
Da Narita, il paesaggio è un’immensa prateria di case a cubetto, come se fossero state appena tirate fuori dalla scatola di giocattoli di un bambino gigante, o di Godzilla da cucciolo.
L’immaginazione fotografica risulta costantemente sovreccitata, mentre coriandoli di zen ristagnano in un vaso ikebana o in un vasca di pesci rossi all’ingresso di un Konbini.
I sensi, in mezzo a questo impero dei segni, avanzano a tappe in un singolare percorso di apprendimento in cui, nella maggioranza dei casi, si finisce per non capire nulla. Montaigne viaggiò in Italia per imparare il fascino della conversazione. La conversazione, in Giappone, per chi non conosca il giapponese, non è esattamente la parte essenziale del viaggio. Si resta piuttosto in un ambito introspettivo, anche nel caso una gentilissima signora, pallida come la luna, si offra di mostrarci la strada per il nostro albergo.
Le guide turistiche servono a poco. Non ci sono archi di Traiano in attesa di turisti, intonsi da un paio di migliaia di anni. Il tentativo di segnare la città con un landmark – la torre di Tokyo, questa replica a colori dell’Eiffel – è risultato tra l’imbarazzante e il deliberatamente comico. È servito a stampare qualche maglietta, le calamite per il frigorifero o una di quelle palle di vetro con la neve che cade, se proprio non si dovesse riuscire a fare a meno di comprare un souvenir.
La linea di esplorazione della città non è verticale, per quanto, da Ginza a Shibuya e Shinjuku, il campionario di verticalità possa essere decisamente nutrito. La torre di Tokyo, con quel suo appoggiarsi un pò goffo, come se avesse dovuto schiacciarsi per restare in equilibrio, dice che non bisogna guardare troppo in alto. È preferibile restare coi piedi ben piantati a terra. Come nella celebre fotografia Stray Dog di Moriyama, la condizione ideale per esplorare Tokyo è quella del cane randagio. È un invito a posizionarsi sui margini, quasi osservando a una certa distanza, con un cannocchiale rovesciato, mantenendo tutto un pò lontano, rimpiccolito in prospettiva.
Stray Dog è anche il titolo di un vecchio poliziesco di Kurosawa, ambientato nel dopoguerra, una sorta di versione nipponica del neorealismo italiano. La forma attuale della città, nella sua ininterrotta routine di distruzione e costruzione, arriva in effetti dalle macerie, dalla polvere, dall’euforia e dalla vorace e disperata energia di quel momento. L’orgoglio e lo spirito di sacrificio hanno fatto il resto. Dà la vertigine pensare alla quantità di sudore necessaria per strappare Tokyo al caos.
Il caos giapponese è uguale a tutti gli altri caos del mondo. Non vede l’ora di entrare nella stampante della perfezione. Di frequente, produce apprezzabili istanti equilibrio: un’architettura minimalista, una pagina di Murakami, un manuale di Marie Kondo. Si tratta naturalmente di un effetto temporaneo. La cosa più interessante restano i momenti in cui la macchina si inceppa, come se all’improvviso apparisse ad un incrocio o davanti a una vetrina lo spinning disk di un computer impallato: brevissime scene di arte concettuale che nessuno ha pensato come arte concettuale.
Difficile, come idea, definire il futuro. È un’immensa baraonda che aspetta di mettersi in fila. Le file di Tokyo sono bellissime. Sono capaci di girare intorno a due isolati, pur di non invadere la seconda corsia del marciapiede. Può capitare di aver nostalgia Tokyo solo pensando a una fila fatta per comprare una scatola di biscotti, o una ciotola di udon caldi in una fredda serata d’ottobre.
Photographs Ernesto Tedeschi