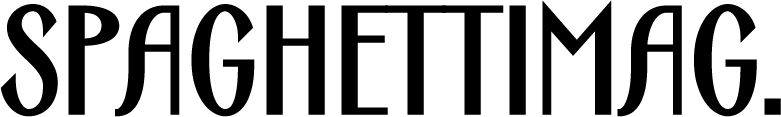Vestire è comunicare, e quello che comunichiamo varia in base alla nostra personalità, a come ci sentiamo, al tempo che viviamo. La moda da questo punto di vista è una specie di conversione visiva di quello che pensiamo e sentiamo.
Se infatti non tutti abbiamo accesso alle stesse possibilità, tutti abbiamo accesso al nostro corpo, e scegliere di abbigliarlo in un determinato modo piuttosto che in un altro, fa della moda non soltanto un linguaggio, ma anche uno degli strumenti politici più facilmente disponibili.
Malgrado il suo immutabile status di merce, la moda ha un enorme potenziale politico. Al di là del contesto culturale di un capo, di quanto è costoso o della sua portabilità infatti, è fondamentale il modo in cui i nostri vestiti, e per estensione, noi, veniamo percepiti dagli altri.
Come concetto, la nozione di moda politicizzata è naturalmente molto ampio, considerando tutte le implicazioni del termine, e molto antico, dal momento che moda e politica vanno a braccetto da quando le persone hanno cominciato a vestirsi.
Storicamente l’abbigliamento è stato un segno di potere, utilizzato per veicolare autorità, valore morale, ricchezza, rango. Sicuramente è stato, ed è ancora in parte, uno dei principali canali attraverso cui il patriarcato ha oppresso le donne con l’uso di corsetti strettissimi, gonne troppo strette o troppo larghe, crinoline e tacchi spillo.
Ma è stato anche, di contro, uno degli strumenti con cui le donne si sono prese una rivincita, vedere alla voce: armatura di Giovanna d’Arco, o a quella pantaloni, fino ad arrivare alle spalline imbottite degli edonistici e patinati anni ’80.
L’abito ci consente di rivendicare uno spazio, di appartenere a un gruppo e di mettere in discussione narrazioni e imposizioni.
Può accentuare o diminuire le disuguaglianze. Può sfidare le strutture del potere, può cambiare il modo in cui vediamo noi stessi, e promuovere nuovi standard di bellezza.
Può mettere in discussione il binarismo di genere e addirittura reclamare standard produttivi più sostenibili.
Per questa ragione la moda non è mai apolitica. Anche la decisione di non interessarsi alla moda è un’affermazione politica. Il famoso monologo “blu ceruleo” di Miranda Priestly ne Il diavolo veste Prada svela solo in parte il primo strato dell’impatto universale che il fashion system ha sulla società.
L’uso della moda come veicolo di espressione politica non è una novità, ma in tempi turbolenti, la sua immediatezza può essere molto forte. Lo sa bene Rei Kawakubo, la stilista giapponese che sin dagli inizi della sua carriera si è mossa tra i confini della moda e dell’arte per distruggere (una delle sue prime collezioni si chiama Destroy) tutti gli stereotipi femminili.
Considerata una delle designer più estreme in circolazione, ha cominciato a sperimentare le sue decostruzioni fuori dal tempo mentre nel mondo imperversavano i figli dei fiori e le minigonne di Mary Quant. Il suo stile, eccentrico e oscuro, si è guadagnato il titolo di “Chic trasandato”, “Hiroschima chic”, o “Post atomico”.
In realtà, per definirla basterebbe anche soltanto la parola “Anti-glamour” vista e considerata l’attitudine che nel tempo ha fatto di Comme des Garcons, il marchio che lei stessa ha fondato a Tokyo nel 1969, un emblema della resistenza all’estetica dominante.
Al centro delle sua creazioni oltre alla rielaborazione continua del rapporto tra abito, spazio e corpo, anche quello fra equilibrio e squilibrio delle parti, simmetrie e asimmetrie e tutte le oscillazioni minime che dal perfetto producono l’imperfetto.
Nonostante dal 2015 si rincorrano voci di un suo possibile addio, a 77 anni non ha la minima idea di ritirarsi. Neo Future, è l’ultima collezione A/I che ha realizzato per Comme des Garçons.
In un momento in cui il presente è minacciato da una nuova imminente crisi economica, e la gente è sempre più incapace di provare empatia di fronte alle innumerevoli tragedie umanitarie e l’odio è pane quotidiano, Kawakubo, cerca nel futuro l’antidoto per sfuggire a tutto questo.
Si chiede se è ancora possibile fare qualcosa di completamente e interamente nuovo. Se è possibile produrre ancora utopie in un mondo impazzito in cui i bambini sono tenuti in gabbie da Trump e l’europa spara sui profughi in fuga dalle bombe.
Neo Future parla di tutto questo e forse anche di più. Parla del dolore e dell’ accettazione, di diversità, di omologazione e di gender bender, prospettando nuove forme di emancipazione femminile nell’era del me too.
La collezione sotto tutti i punti di vista è un tentativo di insurrezione che capovolge i dettami dello stabilito e della perfezione facendo dell’irregolarità, delle storture e della deformità il suo grido di battaglia.
Il futuro a cui guarda Comme des Garcons è un futuro in cui il dibattito sui ruoli di genere non si risolve nel vestire le donne come uomini e viceversa, ma trasformando i vestiti in architetture genderless, in cui gli innesti e i grumi di tessuto riempiono la figura fino a renderla indecifrabile.
Le stesse architetture plastiche, in passerella circondano i corpi delle modelle ma senza opprimerli, come fossero gabbie gentili che le proteggono.
E tende di pizzo pendono da aloni sagomati intorno alle loro teste.
Bozzi di tessuto crescono e si arrampicano sui vestiti per spostare gli abiti o per ritagliare aperture mistiche sugli ombelichi.
É un futuro strano, capriccioso, anarchico, in cui è impossibile identificare le parti; distinguere le gonne dalle maniche a sbuffo. Il sotto dal sopra. Il davanti dal dietro.
Kawakubo sfugge alla regolarità del pensiero e a quella dei capi.
Un gioco di distruzione e assemblaggio per eludere i controlli dell’omologazione, verso un mondo libero dai preconcetti e dalle tendenze.
Un attentato al buon gusto e al senso comune di cuori rovesciati e ultraterreni nei pantaloni e nei capelli.
Di tessuti drappeggiati e cuciture irregolari, imprecisioni e asimmetrie marcate.
Non è un modo per lanciare una tendenza, è qualcosa di più pericoloso, è un modo per lasciare a noi la scelta; se prendere possesso del nostro corpo per opprimerlo o per liberarlo.
Una bomba pronta per esplodere.