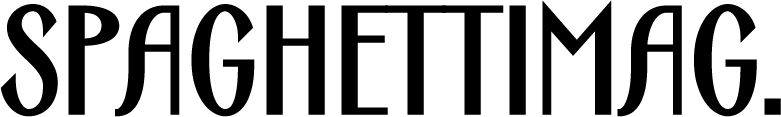Il cinema e la moda, un carosello gigante, ed è subito performance.
È un rito che non ammette repliche quello presentato da Alessandro Michele per Gucci, è lui stesso a dichiararlo in una lettera scritta a mano pubblicata poco prima della sfilata su instagram.
È un elogio al cinema, all’arte dello spettacolo, e a dirlo è Federico Fellini, la sua voce rimbomba nel Gucci Hub e parla del “circo” creato dalla sua crew sul set come atto d’amore per il cinema.
Una sfilata che è una performance: una grande pedana rotante mette in mostra ciò che avviene nel backstage, gli stylist vestono le modelle in presenza del pubblico, una volta pronte, si allineano di fronte a questi, rende omaggio e mostra quella “intelligenza collettiva che cura la gestazione con brivido che infuria” e che normalmente rimane taciuta, nascosta, dietro le quinte appunto, sul finale le modelle abbandonano la scena dando spazio a chi lavora dietro le quinte.
Quando le modelle sono perfettamente allineate avanti al pubblico, esce la vera essenza della creatività di Alessandro Michele: ridefinire la normalità come un insieme di infinite, stravaganti, sbagliatissime e scoordinate individualità dove non esiste regola, ma soltanto l’anarchica autogestione dell’espressione di sé. Accarezzare quella nostalgia d’umano che altri chiamano imperfezione.
La collezione in sé è la continuativa della maschile di Gennaio in cui, come sempre, lega insieme i capi più disparati: tailleur classici, abiti vittoriani, completi di ispirazione goth e cappelli da quacchero, dalle Mary Jane con la zeppa ai maxi volant e alle collane con grandi crocifissi dorati. L’opulenza oggi è rappresentata dalla sovrapposizione, dal mescolamento di tessuti ed elementi e dalla molteplicità di accessori.
Del resto l’invito parlava da sé, già definito il più green di questa fashion week, una nota audio che invita gli ospiti ad andare nel Gucci Hub per lo show, concluso da un “fammi sapere eh. Baci”.
Il testo della lettera pubblicata da Alessandro Michele su Instagram:
Un rito che non ammette repliche
Ho sempre pensato alla sfilata come a un accadimento magico capace di sprigionare incantesimi. Un’azione liturgica che sospende l’ordinario, caricandolo di un sovrappiù di intensità. Una processione di epifanie e pensieri dilatati che si accomodano in una diversa partizione del sensibile.
In questa festa che si nutre di attesa, il mio pensiero trova la sua forma e si fa pubblico. Annoda ossessioni e spinte antigravitazionali. Sosta sull’improbabile. Accarezza quella nostalgia d’umano che altri chiamano imperfezione. Cuce, con la precisione dell’amore, ogni più piccolo dettaglio della scena per offrirlo a una comunità di interpreti.
C’è l’incanto del dono, in questo rito che non ammette repliche. C’è la promessa di una consegna preziosa. Le luci si spengono. Gli adunanti sostano in attesa, con mani aperte. Tutto tace perfettamente, per accogliere i miei battiti storti e le mie vertigini.
A questa tribù di spettatori emancipati offro la mia poetica. Che ne facciano interrogazione profonda. Che mi aiutino a comprenderla. Potranno tradurla o tradirla. Usarla per ridestare domande sopite. Oppure semplicemente respingerla, in assenza di varchi di compassione. Il dono è materia viva, un rebus il cui significato non appartiene a nessuno.
Anche oggi abiteremo questo rito, per me sacro. Un corteo di passi disegnerà lo spazio, come rintocchi nel tempio. Misteriose imbastiture presteranno il loro giuramento alla luce. Una partitura di note magnificherà profezie impresse su corpi in movimento.
C’è tuttavia qualcosa che, in questa cerimonia, solitamente rimane sepolto: lo sforzo del partoriente che accompagna il tremore della creazione; il ventre materno in cui la poesia, da forma a forma, fiorisce. Ho deciso quindi di alzare un velo su ciò che ama nascondersi. Che esca dall’ombra quel miracolare di mani sapienti e di respiri trattenuti. Che si faccia visibile quell’intelligenza collettiva che cura la gestazione, con brivido che infuria. Che si costruisca un trono per quell’alveare scalcagnato e un po’ folle che ho scelto come casa.
Perché quella è la casa che venero: il varco benedetto attraverso cui la bellezza esce dal guscio.
Alessandro