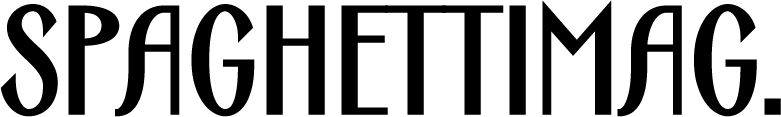Sara Ricciardi è una designer che progetta prodotti per aziende, pezzi unici per gallerie, e performance, interni e installazioni.
Beneventana di nascita, oggi vive e lavora a Milano dove si divide fra la NABA dove insegna Social Design e pratiche relazionali, la Domus Accademy, il suo studio e The Ladies’ Room, il collettivo che ha fondato insieme alle progettiste Agustina Bottoni, Ilaria Bianchi e Astrid Luglio, con le quali crea progetti sensoriali per varie gallerie.
Durante il Pitti 2019 ha inaugurato il suo primo concept store chiamato “Eden”, aprendo così una progettazione dedita all’interior design, per il lancio della capsule collection del brand Attico presso il negozio di alta moda Luisa Via Roma a Firenze, ma tra i brand per cui ha collaborato ci sono anche Visionnaire, Houtique, Coin Casa, Culti e Giorgetti.
L’ho incontrata a EDIT, mentre si prendeva una pausa facendo due passi nel Museo Filangieri (altra location della fiera) e dove mi ha raccontato l’amore per la filosofia e quello per la materia, la passione per il collezionismo e la ricerca delle possibilità ma soprattutto che la forma, segue sempre il messaggio.
Ciao Sara, ti definisci “camparda”: ci spieghi cosa significa questo nella tua quotidianità?
(Ride). Innanzitutto trovo che sia potentissimo avere le radici che si alimentano da più territori, nel mio caso in principio sono state la Campania e Benevento, dove sono nata, poi Milano. Sono sempre stata molto riconoscente verso la mie origini. Benevento è una città silente, esoterica, dalle frequenze basse. Mi ha dato l’energia narrativa, il modo di ricercare, nei libri o nel teatro, le sperimentazioni linguistiche e concettuali. Ma più crescevo, più mi rendevo conto che avevo bisogno di ricercare dei linguaggi nuovi e diversi che a Benevento non riuscivo a praticare, avevo bisogno della materia, del corpo, e quando mi dissero che a Milano c’erano scuole di design nelle quali potevi mettere su carta quello che avevi in testa e realizzarlo, pensai che fosse arrivato il mio momento. La Lombardia e la Campania sono i due posti in cui mi sono stabilizzata. Essere camparda significa questo; le due parti di me che si bilanciano.
E’ in parte anche questo, quello che intendi, quando dici che “la forma segue il messaggio”?
Il linguaggio è una cosa a cui tengo molto. Platone lo spiega molto bene nel Timeo; parla del Demiurgo che dal mondo delle idee riesce a plasmare con la materia piccole dosi da dare agli uomini. Il sistema universale è talmente complesso che noi abbiamo bisogno di pillole, di piccole parti per capire tutto il resto. La forma segue il messaggio perchè in principio era il verbo e tutto si crea nel linguaggio, nella maniera in cui si dicono le cose. Significa che la materia viene dopo. Sono andata a Milano con questo sogno di creare materia e per rendere “più fisico” quello che avevo in testa. E’ stato il mio momento demiurgico.
Leggendo la tua biografia sono rimasta colpita dalla varietà di interessi e di mondi che sfiori quotidianamente con il tuo lavoro; dal teatro greco alle storie di streghe, dalle “cascate di libri” ai disegni sui muri. Che peso ha la contaminazione nello sviluppo dei tuoi progetti e nel design secondo te?
Una volta, anni fa, ho partecipato ad un workshop di Fabrica in cui mi chiesero di scrivere una parola su una bandiera che avrei dovuto portare con me e sbandierare; io scrissi “contagio”. Credo che contaminare e lasciarsi contaminare sia fondamentale. E’ imprescindibile; se tu ci pensi i vaccini sono delle contaminazioni, e noi stessi contaminiamo costantemente gli altri di entusiasmi e di cose positive ma anche di cose negative. Siamo e viviamo un continuo processo di scambio con gli altri, con gli oggetti, con le persone e in queste transumanze energetiche accade qualcosa di importante, ci si trasforma. Siamo ingredienti alchemici che si trasformano in base a quello che accade, nell’avversità come nelle bellezza. Ovviamente è un processo facilitato quando si tratta di cose belle, ma anche le cose brutte, se non ci abbattiamo, possono dare vita a fioriture pazzesche, molto più interessanti. Credo fortemente che dobbiamo essere sempre aperti al nuovo e che dobbiamo essere sempre disposti a lasciare entrare e a superare i nostri limiti. Una delle mie ultime installazioni si chiamava Crocevia e nasce come una risposta al distanziamento sociale. L’umano deve incontrare l’altro umano, i miei oggetti servono per incontrare gli altri.
A proposito di confini, quale è il tuo rapporto con l’idea di limite?
Il limite è un obiettivo. Quando ci capitano delle cose difficili siamo in grado di formulare un sistema di rifacimento e superare noi stessi. Quando sei in emergenza riesci a creare delle nuove narrative dei nuovi modi per reagire e io trovo che quella sia la cosa più interessante degli esseri umani. Le installazioni servono ad abbattere i confini e a creare un rapporto tra le persone e tra le persone e gli oggetti. Ultimamente sto lavorando molto con gli spazi perchè credo riescano ancora meglio ad esemplificare le dinamiche dell’incontro e dello scontro.
C’è qualche progetto al quale hai lavorato e a cui ti senti particolarmente legata?
Con ogni progetto sono riuscita a conquistare qualcosa, a superare dei limiti, appunto. Sono tutti importanti. Tutti mi hanno fatto conoscere meglio me stessa. Sono come delle gravidanze, dei parti. Li vedo come sperimentazioni materiche e personali che mi hanno portata qui, quindi sono grata a tutti in egual misura.
Come ti vivi la commissione?
Adoro il fatto che le persone mi chiedano un lavoro. Mi sembra magnifico che qualcuno mi chieda un supporto. Si tratta di design, quindi di spazi, oggetti e progetti, cose che conosco bene, eppure nonostante questo ogni volta è una sfida. E’ come il gioco in cui devi unire dei puntini, ce l’hai presente? Il committente ti da i suoi puntini, tu hai i tuoi in base alla tua personalità, il contesto contemporaneo, la storia il sociale te ne danno degli altri, il budget? Sono altri puntini! E’ pazzesco, ma dentro questi punti fissi, riesci a creare un’infinità di percorsi diversi e cose incredibili. Il fatto di sfidarsi ogni volta a collegare quei puntini in modo diverso, facendo ghirigori pazzeschi. Non mi annoio mai e con i committenti si crea sempre un rapporto bellissimo.
Domanda di rito: se fossi un capo o un’accessorio, cosa sceglieresti di essere?
Sono un’amante sfegatata delle pettorine le pettorine come quelle dei santi a cui bisognavano aggrappare anelli e desideri. Quelle sorte di agglomerati da petto incastonate di gioielli, desideri e invocazioni. Le donne berbere e nomadi si cuciono addosso così il loro tesoro e lo espongono dal petto, che è dove si apre il cuore. Mi piace moltissimo che in questo accessorio ci sia da subito una sorta di apertura della propria identità e del proprio cuore verso l’altro, il fatto di portarsi i propri tesori addosso e darsi agli altri con coraggio mostrando il proprio passato e la propria identità.